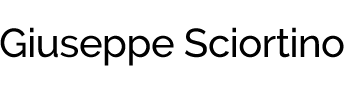Giuseppe Sciortino è un pittore che non avrebbe bisogno di presentazioni, se il suo carattere riservato non lo relegasse nell’intimità di una contemplazione che rende la sua esistenza privatissima, poco propensa alle luci della ribalta. Vive a Firenze, nasce a Palermo nel 1988. Il destino lo conduce nel capoluogo toscano, epicentro di una cultura di cui è uno degli ultimi autentici eredi, piuttosto lontana, benché non del tutto estranea, agli eccessi barocchi della regione natale.
Studia in Accademia di Belle Arti ove assimila con cognizione, e non senza attriti, i tradizionalismi impartiti dal maestro Adriano Bimbi, progenitore di generazioni di epigoni dalle quali, di tanto in tanto, emerge qualche autentico talento quale Sciortino è: la sua arte, se paragonata a quella fangosa prodotta nelle aule accademiche da studenti inesperti, brilla di una ordinata luce neoclassica. Eppure, a ben vedere egli ha poco a che fare con le armonie stentoree di un classicismo sempre meno compreso man mano che il tempo avanza. Non è qui che indagheremo cosa dovrebbe essere ‘il classico’ e cosa effettivamente invece è; in pochi, anche tra i suoi sostenitori (figuriamoci fra i detrattori) saprebbero rispondere. La risposta dell’enigma si risolve, fortunatamente, nel silenzio delle immagini: De Chirico l’aveva certo capito, e infatti la Firenze dove siamo gioca un ruolo fondamentale nella genesi della sua metafisica, oltre che quella del nostro: l’eloquenza della bellezza ammutolisce qualunque commento a sproposito, ed è ciò che l’arte di Sciortino riesce a fare, sintetizzando in sé varie misure della tradizione pittorica italiana ed europea.
Come dicevo prima, è arte di contemplatore: egli è un artista la cui autonomia si basa su di un’analisi approfondita del percepire, al di fuori delle correnti e oltre le mode. La pittura, mezzo che più di tutti è in grado di articolare lo sguardo, gli permette di esternare gli esiti delle sue riflessioni in immagini che, oltre l’apparenza di una pittura colta, nascondono imprecisioni, traccheggi, rimostranze e insicurezze. La pazienza del pittore solitario, sua vera capacità, che poco ha a che spartire con mitologie romantiche, ma forte di una sapienza artigianale costruita in anni di tirocinio, appiana qualsiasi difetto espressionista sotto la superficie di un dipinto puntiglioso, quasi fiammingo, che nasconde qualsiasi falsa partenza oggi troppo spesso spacciata per opera finita.
Il tracciato segnico della pittura contemporanea è molto spesso primitivo, istintivo, spontaneo. Sciortino non lo è: egli è cerebrale, costruito, manierista (nell’accezione positiva e colta del termine), ma non necessariamente in antitesi con ciò da cui, con tiepida determinazione, si distanzia.
Nell’architettura delle sue opere infatti, qualche ripensamento rimane visibile: sono le tracce della condizione umana incapace di ottenere una perfezione tanto anelata, a cui Sciortino, finalmente, rinuncia; ne denuncia anzi l’inesistenza tramite questi quadri i cui difetti (per lo più geometrici: prospettive sbilenche, in corso di appiattimento assonometrico) rimangono appena percepibili. Rimanendo presenti, influenzano l’intero aspetto dell’opera nonché la sua assimilazione percettiva. Per questo, benché ‘tradizionali’, i dipinti di Giuseppe non si iscrivono nell’alveo del classicismo o dei discorsi ad esso correlati: se gli antichi templi erano costruiti con accorgimenti ottici tali da perfezionarne la visione d’insieme, nelle opere di Sciortino, trucchi analoghi nutrono l’intenzione opposta; essi conducono l’immagine imperitura nel regno della vacuità contemporanea, le cui celebrazioni dell’individualismo, dell’arbitrarietà e dell’errore contaminano la visione di un pittore che, però, sembra fuori tempo, antico, ma che in effetti è invece attualissimo. A maggior ragione da contestualizzare nell’oggi, dato che egli, non lasciandosi dominare da alcuna di queste influenze pur accogliendole, sarebbe da prendere ad esempio per quei molti, poveri artisti che si piegano invece completamente al volere dell’ideologia.
La sua disciplina è quella dell’artista medievale toscano che ascende verso un’ideale naturale, ma le sue opere nascono da moderne riflessioni sull’immagine e sul suo statuto nella società odierna. La pittura di Sciortino non può prescindere dalla fotografia, fondamentale strumento per rallentare una realtà in perpetuo movimento, la quale viene poi sigillata definitivamente nel quadro: un’arte che riprende la (sempre attuale e altrettanto stupida) querelle impressionista, quella della pittura versus immagine meccanica, coagulandone alcuni esiti in questa apparenza realista, capace di polarizzare lo sguardo dell’osservatore nei minuti dettagli, facendolo entrare in una realtà alternativa, apparentemente piena di contraddizioni come la nostra, eppure coerente come solo certa pittura sa essere. Le immagini sciortiniane sono verosimili, ma non del tutto; danno l’impressione di entrare (di soppiatto) in ricordi altrui, o in casa d’altri, magari quella di quella zia che un po’ ci intimoriva da piccoli: c’è un che di disturbante in queste opere. Sono anche sinestetiche, dato che riescono a farti respirare la polvere dipinta sui pavimenti e le superfici di mobili scorciati, alcuni tra i soggetti prediletti del nostro. Sono quadri intrisi dei valori tattili berensoniani: si contrappongono con silenziosa decisione alla piattezza pixelata degli schermi.
Le inquadrature sbilenche, le tinte opache e la ricercatezza compositiva fanno sembrare le sue opere ritagli di vita vissuta, rimembranze di un fotogramma fugace e poetico che catturiamo viaggiando in treno, oppure quando, uscendo di casa, cogliamo con la coda nell’occhio un dettaglio casalingo che pacifica per un istante la frenesia della corsa al lavoro. A volte quel ricordo acquisisce una forza propria, e si ricompone nell’emergere di forme inconsce, che nell’arte di Sciortino diventano rare composizioni fantasticheggianti: l’equivalente fisico dei sogni ricorrenti che abitano le nostre menti, e che lui manifesta dipingendole metafisicamente, talvolta infarcendole di riferimenti concettuali.
Ma la partenza è sempre nel reale, in ciò che si vede e che, elaborandolo, si ricorda e riassembla nei corsi e ricorsi mnemomici della mente.
L’arte di Sciortino vuole arrivare a metà strada tra noi e il noumeno, focalizzando le potenzialità espressive rintracciabili nell’apparente banalità del reale, di dettagli insignificanti, in realtà capitali. I suoi dipinti rischiano talvolta di somigliare a cartoline, anche a causa delle dimensioni quasi sempre ridotte, ma sono cartoline importanti, di quelle che si conservano perché documentano qualcosa di fondamentale. Sciortino si immerge nel vacuo, nel banale, in ciò che normalmente non osserviamo più, e ne evidenzia la straordinarietà: col potere dell’intellezione sulla visione, dispiega il mero, ristretto stimolo empirico in ampiezza riflessiva, da esplorare oltre i confini del dipinto.
E’ un artista francescano, lavora tanto per far poco, ma in quel poco brilla una scintilla di universalità che faremmo meglio a non disperdere o dimenticare.
Queste sono le cose che, a braccio, mi vengono in mente sull’arte di Giuseppe Sciortino. Normalmente le mie interviste vorrebbero essere implementate con mie analisi critiche sul lavoro degli intervistati: in questo caso non ce ne è stato troppo bisogno, perché Sciortino ha dato delle risposte talmente articolate che la critica è venuta fuori da sola, come se avessimo fatto delle sedute di psicoanalisi artistica in due.
Dunque, dopo questa breve introduzione, propongo lo scambio di missive così com’è avvenuto, senza correzioni o modifiche, convinto che sosterrà esaustivamente l’esame delle questioni qui da me appena accennate.
Devo dire, una delle chiacchierate più belle che ho fatto sui temi di nostra quotidiana ossessione.
Mettetevi seduti comodi e buona lettura.

Direi di partire da un tema sicuramente caro a entrambi noi e a molti altri artisti in Italia: l’Accademia. Abbiamo studiato entrambi a Firenze, anche se ci siamo conosciuti solo dopo la fine dei tuoi studi. Voglio partire da qui perché oggi va quasi di moda sostenere che le Accademie siano inutili: pare che oggi sia quasi oramai meglio non studiare proprio arte, ma farla per conto proprio. Al netto degli ovvi, numerosissimi problemi che infettano la qualità degli studi praticabili in questa istituzione, ho il sospetto che invece per te, come per me d’altronde, l’esperienza accademica non sia stata da buttare. Tu hai studiato da Adriano Bimbi, un maestro oscuro che veniva aspramente criticato soprattutto per l’omologazione esistenzialista che pareva imporre ai suoi studenti: anche a occhio, guardando i lavori, se qualcuno studiava da Bimbi, si capiva al 90% dei casi.
Tu, pur accostandoti al suo amore/ossessione per il dato naturale, verista1 (Nota: ricordiamo che Bimbi fu a sua volta discepolo di Farulli, un pittore politicamente schierato a sinistra che si narra portasse gli studenti a disegnare nelle fabbriche, cosa che molti artisti successivi hanno poi continuato a fare: una sorta di realismo socialista, che in Toscana è facile ricondurre poi alla tradizione rinascimentale soprattutto donatelliana), hai tralasciato completamente l’apparenza raffazzonata, tenebrista e confusa tipica delle opere della maggior parte dei suoi epigoni. Prima di chiederti specificatamente riguardo la tua pittura, volevo sapere come ti sei relazionato all’ambiente accademico: quanto ti è servito confrontarti con una varietà di insegnamenti spesso in contraddizione reciproca, se pensi che l’Accademia sia un’esperienza comunque da fare. Spesso, e questo è stato il mio caso ad esempio, dopo la distruzione delle aspettative generali, e oltre l’appiglio offerto da quei pochi docenti veramente bravi, ci si sopravvive dentro solo trattando la fauna locale come una galleria di esempi negativi: si impara cioè cosa non fare per fare l’arte che si vuole.
– Tendenzialmente la mia esperienza accademica è stata positiva, non posso lamentarmene. Ma questa è un’opinione che mi sono fatto molto a posteriori e relativamente di recente. Quando frequentavo l’accademia, dai 19 ai 22 anni , e in particolare la scuola di Bimbi, soffrivo molto l’esclusione dalla cerchia degli allievi prediletti del professore, e la soffrivo giustamente in quanto diventai presto consapevole della mia immaturità artistica e umana, e della mia inadeguatezza rispetto al luogo in cui mi trovavo. Sembrava quasi che in quell’aula vigesse sottintesa una sorta di ‘legge naturale’ del più forte, che il professore in un certo qual modo assecondava, anche se non lo dava a vedere palesemente. Questo fatto era necessario in quanto la scarsità oggettiva degli spazi non permetteva a tutti di poter frequentare l’aula e poter lavorare serenamente nel luogo che sarebbe spettato di diritto. Insomma, la scuola risultava essere quasi un rimando metaforico alla disfunzionalità della vita reale fuori dall’Accademia. Quella situazione in quel periodo produsse in me e nella maggior parte dei miei colleghi un grande sconforto, che mi portò ad una definitiva rassegnazione costringendomi a dipingere esclusivamente a casa. Oggi vedo quel momento come molto formativo, nel senso che so per certo di potermi aspettare pochissimo dalle istituzioni o dagli altri in genere e che per andare avanti è necessario darsi da fare di propria iniziativa. Tutto ciò comunque, a causa della mia debolezza di carattere, mi portò ad allontanarmi dalla sua scuola (nonostante fossi sempre iscritto) e a frequentare alcuni amici e conoscenti dal prof. Canale. Lì infatti conobbi un mio caro amico col quale condividevo la passione per tutto ciò che si poneva all’opposto di ciò che professava Bimbi e la sua scuola: il classicismo, e in particolare le sue varie declinazioni moderne, che mi hanno portato in seguito a scrivere una breve tesi sul pittore che in quel periodo mi appassionava maggiormente, Anton Raphael Mengs. La mia formazione iniziale infatti non è avvenuta fisicamente nell’aula di Bimbi se non quando mi recavo lì per disegnare il modello dal vero (nonostante le frustranti e irrazionali condizioni in cui ciò accadeva), ma principalmente in giro per i musei a Firenze e un po’ in varie città italiane, nelle quali mi recavo in occasione di qualche mostra.
Questo allontanamento iniziale e l’insopportabile mitopoiesi della sua scuola, coronata da una certa aura di inaccessibilità, non mi ha però impedito di prendere ciò che di buono e di profondo c’era nelle idee e nella persona di Bimbi, ovvero una certa attenzione verso il dato reale e le sue più svariate manifestazioni sensibili, intrise sempre di una qualche verità poetica. Insomma quello che Bimbi mi ha trasmesso, a parte l’insistenza verso alcuni valori comunemente ritenuti ‘tradizionali’, se non addirittura anacronistici come l’idea di ‘bellezza’, è una maggiore sensibilità e attenzione verso la ‘contraddizione’, intesa in un senso filosofico esistenziale di derivazione principalmente Camussiana. Quindi, quello che dici su Bimbi in parte è vero ma in parte anche no: io l’ho vissuto dall’interno non condividendone o non comprendendone bene i principi, e trasversalmente l’ho potuto confrontare con altre realtà accademiche. La sua scuola ha funzionato grazie al carisma della sua persona (per chi credeva alle sue parole) e al fatto che ha dato la possibilità ai suoi studenti più intraprendenti di lavorare soprattutto fuori dall’accademia, cosa che ho fatto io per i successivi 6 anni, dopo essermi diplomato. Diciamo che il mio quasi congenito scetticismo verso gli artisti e non solo (soprattutto quelli caratterizzati da comportamenti riconducibili ad una certa bohème romantica o esistenzialista) mi ha permesso di andare dritto per la mia strada, aiutato dal confronto in Accademia con altri colleghi che condividevano i miei stessi interessi, dedicando lentissimo ed immane sforzo nel capire il realismo esistenziale che caratterizzava lo stile dei migliori studenti di quella scuola. E devo dire che Bimbi mi ha sempre sostenuto nel portare avanti la mia ricerca, a volte con una certa fatica e anche cambiando idea su certe cose, ammorbidendo negli anni il suo carattere e il suo approccio divenuto gradualmente più liberale, senza impormi le sue idee, né a me né ad altri miei colleghi e tuttora amici che si sono trovati in una situazione simile alla mia. Con quell’uomo bisognava semplicemente insistere e mostrarsi davvero interessati alla pittura e a tutto ciò che comportava, disarmandosi di tutto il pregiudizio che poteva accumularsi in quell’ambiente.
Proprio dopo il mio diploma infatti ho iniziato a legarmi personalmente ed emotivamente a Bimbi e a conoscere con ancora maggiore attenzione e apertura i suoi principi e quelli dei suoi studenti più promettenti. Non lo ritengo un mio maestro (non riesco a concepire questa definizione) ma sicuramente è stato paradossalmente un ottimo didatta, letteralmente un professionista della maieutica, e una persona che mi ha dato 2 o 3 consigli su come approcciarmi alle cose della vita e della pittura che mi hanno definitivamente sbloccato dalla mia paralisi esistenziale dei primi tempi, oltre ad avermi dato la possibilità di lavorare direttamente sul campo, inserendomi in varie residenze artistiche e progetti di pittura. Questa in sostanza è stata la mia esperienza personale in accademia, nel bene e nel male.
Di solito sconsiglio vivamente di frequentare un’Accademia di Belle Arti, perché non ho mai ben capito qual è il suo scopo più prettamente istituzionale verso sé stessa e verso il mondo esterno (nel senso che né si fa ricerca sul serio dentro l’Accademia, né si produce occupazione all’esterno inerente al corso di studi intrapreso). Io ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste e di non aver mai preteso nulla dalle istituzioni artistiche scolastiche o universitarie, non avendo mai avuto di conseguenza particolari aspettative o progetti lavorativi. In accademia studiavo moltissimo e cercavo di prendere tutto quello che si poteva prendere dai professori (ne ho avuti 3 o 4 davvero eccezionali) e dai conoscenti. Nessuno mi ha insegnato nulla dal punto di vista tecnico, ho sempre copiato opere antiche, studiato su manuali del passato e confrontato con altri ragazzi che dipingevano meglio di me. Quindi consiglierei a chi me lo chiedesse di iscriversi in un’Accademia solo se si è nelle condizioni materiali per farlo (se si può contare in una rendita, in un lavoro o non si hanno particolari difficoltà economiche) ma anche spirituali (alto grado di sopportazione della precarietà e di una relativa povertà, o ottima elasticità mentale) e solo se ci si è ben informati sui corsi e i professori che eventualmente si andranno a seguire, magari cercando dei feedback da persone che già ci stanno dentro. L’importante è non avere pretese a livello professionale, perché stiamo parlando di un’istituzione che per come è concepita oggi vive di inerzia e si presenta come un mondo parallelo rispetto a quello reale e al sistema dell’arte.
Una volta fuori ci si deve reinventare. –
Stai confermando l’aspetto puramente esistenziale dell’Accademia, che abbiamo entrambi vissuto e che non ci ha garantito un’effettiva, fattuale preparazione al dopo. Si parlava tanto (e si dipingeva anche tanto, anche se mai abbastanza), ma le soluzioni pratiche per la vita, che altri percorsi universitari offrono automaticamente, da noi non erano oggetto di discussione razionale, quanto di fede. A sentire le voci non è una prerogativa dell’Accademia fiorentina: l’arte italiana in genere versa in uno stato di mediocre sufficienza proprio a partire dalla scarsa praticità degli studi artistici. Hai detto che la tua scuola, oltre che alle frequentazioni museali e le uscite nelle altre città, o le compagnie selezionate per affinità elettive, è stata l’intimità casalinga dove dipingevi. L’artista è oggi una figura destinata all'(auto)isolamento?
– Potrei rispondere affermativamente con una certa sicurezza a questa domanda, date le condizioni in cui mi ritrovo a lavorare, ma in realtà non credo che sia così. Io lavoro bene in un totale isolamento, e lavoravo bene in solitudine anche quando ho fatto parte di gruppi di lavoro in diversi progetti collettivi di pittura. Ma mi risulta che un pò ovunque emergano dei piccoli gruppi di artisti, anche molto giovani, che si dentificano in ricerche artistiche comuni più o meno caratterizzate da una certa omogeneità stilistica o linguistica. Non credo che l’artista sia costretto o destinato ad un autoisolamento: c’è chi può lavorare solo in queste precise condizioni e chi invece ha bisogno di lavorare in simbiosi con altre individualità per alimentare le proprie idee e ricevere più stimoli esterni. Diciamo che da quello che vedo in giro mi sembra che molti artisti si riuniscano, inizialmente prendendo uno studio in comune e in seguito (se tutto va bene) cercando di istituzionalizzarsi, spesso mediante l’associazionismo culturale. Credo che ciò avvenga proprio per l’insoddisfazione verso le istituzioni artistiche che si sono frequentate in passato, cercando di creare nel migliore dei modi un micro-sostituto dell’accademia (se non della galleria, in certi casi) con la notevole differenza però di avere uno scopo istituito e chiaro, una riconoscibilità e una funzionalità culturale più specifica. Qusti luoghi condivisi hanno il grande vantaggio di poter essere visitati e frequentati attivamente, creando situazioni di grande confronto formativo e umano in generale. ‘Fare gruppo’ è una buona cosa se la si riesce a gestire con efficacia, perché è più semplice organizzarsi in pochi per presentarsi efficaciemente al mondo.
Da soli è un po’ più complicato credo. I collettivi artistici, se fondati con criterio, danno anche una certa idea di anonimato molto apprezzabile, che fa pensare ad un’arte pre-moderna (ma anche alle confraternite ottocentesche) in cui non era il singolo artista-genio ad essere al centro di tutto ma l’opera o il progetto funzionale. L’elemento interessante è che, a differenza delle confraternite o anche ai semplici gruppi d’avanguardia (dagli impressionisti fino al ‘900 inoltrato), non mi sembra che nel presente ci sia un fondamento ideologico-utopico-totalitario di improvviso stravolgimento rivoluzionario del mondo, ma una semplice e pacata proposta artistica che si inserisce abbastanza bene (quando funziona) nel sistema culturale pluralistico che caratterizza il nostro tempo.
Non so se è un bene o un male, ma di fatto è espressione anche questa del mondo in cui viviamo. –
Sono molto d’accordo con la tua diagnosi. Detto questo, sembra comunque che oggigiorno l’arte non costituisca, nella maggior parte dei casi, un elemento fondativo del nostro essere comunità. Questi collettivi che dici esistono, ma non esiste una sistematicità istituzionale che permetta all’artista in quanto tale di inserirsi nel tessuto sociale: egli deve sempre sforzarsi da sé per trovare una sistemazione. O esistono casi di singoli di artisti celebri capaci di raggiungere il grande pubblico; oppure le situazioni collettive di cui parli sono funzionanti ma nella limitatezza di un piccolo bacino di utenza, nella contingenza di un singolo evento, come la mostra o la residenza estemporanee. Il che è meglio di niente, intendiamoci. Ma anche dato il contesto plurale che evidenzi, è difficile scrollarsi di dosso la sensazione di un’atomizzazione che risulta in una sostanziale disgregazione: molte persone esperiscono resistenze quando provano a inserirsi in determinati ambienti artistici, il dialogo spesso non esiste o è funzionale alla propaganda di specifiche idee, spesso provinciali, su come bisognerebbe fare arte, su cosa essa dovrebbe essere, addirittura su cosa si dovrebbe ritenere giusto o sbagliato. Detto questo, tornare ad una visione gerarchizzata della produzione artistica sarebbe impensabile nonché liberticida, ma non credi che bisognerebbe ristabilire dei criteri, non dico fissi, ma quantomeno duttili (anche politici), per tornare a rendere l’arte un elemento attivamente e sistematicamente partecipe della vita comunitaria ben oltre alle sette di aficionados?
– Non sarei così tanto sicuro del fatto che l’arte non costituisca un elemento fondativo del nostro essere comunità. Certo: sicuramente questa non è l’epoca in cui l’arte o la cultura (in senso umanistico) sono al centro di tutto, come può esserlo la tecno-scienza o l’economia. Se per arte intendi quell’insieme generale di discipline tradizionali e moderne categorizzate in un sistema conchiuso, definito e istituzionalizzato a partire più o meno dalla nascita dell’Estetica e dallo sviluppo conseguente e quasi inevitabile di una ‘religione dell’Arte’, (quindi Pittura, Scultura, Architettura, Arti applicate, Installazioni, Performance, Arti multimediali, Cinema, Teatro, Musica eccetera…) la situazione presenta delle ambiguità e degli evidenti squilibri. L’arte era al centro fondante della comunità nelle epoche preindustriali, quando non si chiamava neanche ‘arte’ ed esistevano solo diverse modalità di produzione di manufatti veicolo di significati e valori condivisi.
Questi squilibri oggi si palesano nell’ambito più prettamente disciplinare e fruitivo: la Pittura o la Scultura non potranno mai competere con il Cinema, il Video, le arti applicate e scenografico-installative, o le arti musicali, parlando solo di ciò che noi consideriamo generalmente una versione contemporanea delle ‘Belle Arti’ fruite anche da persone di media cultura e interessi non specialistici.
Questa tipologia di ‘Arte’, con la ‘a’ maiuscola, invece, potrebbe semplicemente essere un residuo aristocratico-elitario accessibile oggi ad un maggior numero di persone, anche se con la dovuta distanza ‘sacrale’ necessaria alle istituzioni al fine di costruirne un valore difficilmente stimabile, ma funzionale al mercato delle mostre e degli eventi culturali in genere.
Se invece parliamo dell’arte in genere, delle manifestazioni artistiche dotate di una qualche volontà poetica, espressiva, estetica eccetera… (quindi sia di arte ‘popolare’ che di arte ‘alta’), insomma se buttiamo tutto nello stesso calderone senza fare troppe distinzioni, allora sono certo che queste manifestazioni siano assolutamente fondative e che influiscano notevolmente sul pensiero e l’immagine di mondo di tutti gli individui associati in comunità. Queste manifestazioni, potremmo dire ‘estetiche’, risultano essere fortemente pervasive anche se nella maggior parte dei casi si appiattiscono in fenomeni di puro e semplice intrattenimento. Basta pensare a tutto quello che si può trovare su Instagram o nei social in genere, dai meme ai video brevissimi (provenienti da TikTok ma che trovano dei predecessori nei Vines di qualche anno fa, n.d.a.). Sembra quasi che alcune caratteristiche tipicamente attribuibili all’Arte intesa in senso tradizionale vengano più o meno consapevolmente ‘applicate’ a nuove forme di espressione veicolate da nuovi strumenti tecnologici in grado, per altro, di invadere quasi costantemente le nostre vite quotidiane. Insomma: un’artisticità o estetizzazione iper-diffusa.
Non so se si dovrebbero o si possano addirittura ristabilire dei criteri ‘duttili’ per rendere l’arte un elemento partecipe della vita comunitaria. Secondo me , in qualche modo, questi criteri già esistono, anche se non si sa bene cosa sia l’arte e come dovrebbe essere. Ci sono nelle istituzioni inaccessibili (inaccessibili proprio perché evidentemente i criteri sono molto poco duttili) e negli individui (il gusto personale come stratificazione delle proprie conoscenze unita alla propria indole caratteriale). Credo che la questione riguardi un paio di aspetti: la scarsa attenzione e lo scarso interesse che la maggior parte delle persone e del pubblico potenziale rivolge al mondo e a ciò che accade intorno (principalmente per mancanza di tempo e conseguente mancanza di voglia. Si lavora troppo), quindi verso la cultura in genere e di conseguenza i valori che la costituiscono; e il fatto, più soggettivo, che riguarda quelli come me e te che si pongono questo problema, di stare storicamente dalla parte sbagliata. Poi la duttilità dei criteri di cui parli finirebbe credo per liquefarsi totalmente in quanto un criterio può essere malleabile potenzialmente all’infinito da parte di istituzioni o individui. Quindi credo che i criteri esistano già e abbiano un carattere tendenzialmente dialettico, per cui alla fine vince chi impone il criterio più efficace fin quando non arriva qualcun altro ad imporre fermamente il suo (con la forza subdola o con il ragionamento e il confronto). –
Sì, io mi riferivo specificatamente a quelle che vengono (o venivano) considerate strettamente ‘belle arti’, la cui fruzione avviene quasi esclusivamente nei luoghi deputati a tal scopo: musei, fiere, biennali, gallerie. Però hai ragione nel dire che linguisticamente, tutto ciò che è stato sperimentato nel ristretto campo di quest’arte è oramai appannaggio della promiscuità mediale in cui noi occidentali, ma non solo noi, ci ritroviamo a vivere. Il collettivo artistico Luca Rossi, che inevitabilmente seguo, dice che ad esempio, nel selfie “autore, soggetto e fruitore combaciano”, e che i social media sono grandi opere d’arte relazionale. Come a dire, riprendendo la celebre frase di Beuys, oramai siamo tutti inevitabilmente artisti, compartecipando a questa attività di condivisione ossessiva. La descrizione che fai dell’artisticità liquefatta mi fa tornare in mente il celebre saggio di Baudrillard, “La Sparizione dell’Arte”, che descrive proprio questo processo di capillarizzazione estrema che si conclude, però, in una sostanziale assenza: se tutto è estetico, niente lo è più. Come dici dei criteri neo-fondativi possono certamente essere imposti, ma vanno a incunearsi in una catena infinita di annullamento reciproco, in questa dialettica iper materialista che diventa, oramai, a-materiale e tautologica. Però tu dipingi quadri che, in qualche modo, si svincolano da questa continua produzione di contenuti in perpetuo affastellamento: mantengono quell’aura che solo la pittura riesce a conservare, e per quanto possano essere diffusi in rete fotografie delle tue opere, la loro riproducibilità è esclusivamente un fatto di superficie; l’opera pittorica invece si propone come un catalizzatore unico che non può che essere fruito dal vero, dato che presenta un insieme di caratteristiche (come la matericità, la rifrazione della luce, il contesto in cui viene esposta) impossibili da veicolare virtualmente. Quali sono dunque i criteri, oltre l’ovvia predisposizione personale, che ti hanno spinto a questa scelta di campo? Ti senti “dalla parte sbagliata della storia”? Come contestualizzi, anche ma non solo politicamente, il tuo percorso in questo marasma dialettico?
– Quella di fare il pittore inizialmente è stata, più che una scelta vera e propria, una inconsapevole e irresponsabile (non in senso negativo) conseguenza del fatto che mi resi conto che i mezzi che usavo, i fini a cui puntavo e la mia persona stavano in qualche modo fondendosi tra loro. Quando ci si rende conto di questo fatto diventa necessario e naturale praticare una qualsiasi disciplina, spinti da una forza invisibile che non entra più in contrasto con le idee o le aspirazioni personali. Ad un certo punto mi sembra che non si sia più manifestata in me quella frustrante separazione psicologica tra la coerenza del pensiero e dell’azione. Ho continuato a dipingere per una sorta di inerzia positiva e costruttiva. Detto questo, nel corso degli anni, il senso di ciò che facevo è iniziato ad emergere letteralmente e concettualmente: mi sono reso conto che avevo un’opinione della ‘storia’ (e quindi del mio agire in essa) in netto contrasto con un certo idealismo moderno, secondo cui bisognava assecondare la corrente storica dotata, secondo alcuni, di una direzione ben precisa (idea tipica di gran parte del XIX e XX secolo, e di palese derivazione cristiana, e che ancora oggi credo esista sotto forma di residui molto potenti, a volte molto inconsapevoli e non volontariamente ideologici). Insomma: in molti tutt’ora dicono che è assurdo dipingere, anche se le cose mi sembra che stiano cambiando. Il criterio che adotto, non biografico per così dire, è molto semplice: fare arte, dare senso alle cose, non è solo una questione di innovazione tecnica (idea che deriva appunto dall’ideologia di cui parlavo prima). La questione dei mezzi e delle protesi tecnologiche che si utilizzano per svelare significati è esclusivamente soggettiva, ed è un problema che l’artista deve risolvere tra la sua mente, il suo corpo e lo strumento che gli permette al meglio di esprimere idee per mezzo di segni (di qualsiasi genere essi siano). La pittura, come il concettualismo, o l’arte virtuale è un fatto personale e non può diventare criterio di giudizio di valore di per sé. Può diventarlo sempre e solo tenendo in considerazione l’opera nel suo insieme costitutivo, materiale e semantico. Fin quando esisterà del pigmento per tracciare dei segni su una superficie, senza che ciò danneggi eccessivamente qualcuno o quasi, è bene che lo si faccia, perché non bisogna precludersi la possibilità di svelare o di ricevere vecchi o nuovi significati, formali e non, che abbiano un impatto in chi produce o fruisce di quel significato. Alla fine, per citare alcuni aspetti della teoria della “forma del tempo” elaborata da Kubler, esistono e sono rintracciabili storicamente (a posteriori) delle “sequenze” all’interno delle quali ci si inserisce, e necessariamente io, come tutti, sono all’interno di una di queste sequenze storiche. Poi se questa sequenza oggi non va per la maggiore per me non è un problema (politicamente parlando), dato che i criteri generici utilizzati qui ed ora da quelli ‘dalla parte giusta della storia’ appartengono a quel vuoto inafferrabile tra gli eventi chiamato appunto ‘attualità’. Solo ad una certa distanza storica e cronologica le cose possono essere davvero giudicate in modo semi-definitivo o quasi. Da qui infatti la mia enorme difficoltà ad interpretare il mondo e la realtà sociale che mi circonda. Come posso contestualizzare la mia produzione in questo stato di cose? Semplicemente facendo la mia parte nel mio piccolo. Lavoro per me (e lavoro ‘da me’) e per quei pochi che capiscono e condividono quello che faccio. Non ho mai aspirato alla notorietà o a diffondere troppo le mie idee, non ne avrei neanche la forza e gli strumenti intellettuali, e mi muovo con molta discrezione. Ma nonostante ciò inevitabilmente posso dare il mio piccolo contributo costruttivo. I social network mi hanno aiutato un po’ a far conoscere o a dare un’idea anche se superficiale del mio lavoro e del mio pensiero, dato che mi permettono di non addentrarmi troppo nello squallore delle relazioni pubbliche dirette che, purtroppo per me, sono l’unico mezzo per inserirsi nel sistema dell’arte e della cultura in genere. Ma forse non è poi un così grosso problema. –
La tua risposta denota un’incredibile umiltà: non ritieni di produrre arte migliore di quella altrui, per te non esistono dunque gerarchie espressive che pongono determinati linguaggi al di sopra di altri? La tua pittura è guidata da un’esigenza personale, non tanto dalla scelta cosciente di un preciso stile o tecnica che permettano alla tua produzione di primeggiare. Il tuo inserimento in uno dei solchi storici di cui parli appare quasi come una contingenza che non il frutto di una scelta consapevole. E’ anche per questo motivo che (come mi pare tu faccia) dipingi quasi esclusivamente le cose o le persone che conosci? Percepisco una sorta di accettazione delle circostanze nella tua arte, quasi come se non fosse tuo dovere ‘andare oltre’; o meglio, vai oltre, ma utilizzando esclusivamente il conosciuto come strumento d’accesso alla visione artistica.
– Sicuramente non posso dimostrare di produrre arte migliore di quella altrui, posso solo ‘mostrare’ quello che faccio e proporre la mia visione delle cose. In pochi ambiti disciplinari è possibile dimostrare con una qualche certezza che 2+2=4, e l’ambito che ci riguarda in questo contesto credo sia lontanissimo da questi. Io non sono minimamente interessato a dimostrare di aver ragione, e non lo sono anche perché non accetto definitivamente le ragioni degli altri artisti, le tengo semplicemente in considerazione. La mia è un’umiltà più apparente che sostanziale: se non sapessi di avere ragione o un qualche motivo che mi spinge a produrre manufatti dotati di senso probabilmente non farei nulla. Semplicemente non voglio imporre le mie idee per primeggiare, perché non concepisco questo modo di vivere e di agire nel mondo, anche se a volte per motivi legati al lavoro o alla sopravvivenza siamo un po’ tutti costretti. Chiaramente da ciò deriva che per me non dovrebbe esistere nessuna gerarchia espressiva che premia alcuni linguaggi a dispetto di altri, anche se purtroppo mi sembra che da qualche secolo il fine di alcuni artisti o gruppi di artisti sia stato sempre e solo quello di imporre il proprio linguaggio a discapito di altri, giustificando il proprio operato nei termini di una apparente e in fondo indimostrabile ‘originalità’ o peggio ‘innovazione’. Io rigetto fermamente qualsiasi approccio artistico che si propone come ‘avanguardia’ o che pone il proprio scopo come creazione innovativa, perché mi sembra che nulla più dell’idea di innovazione nell’arte (finalizzata necessariamente a superare il vecchio in nome del nuovo, e di agire contro qualcuno o qualcosa, a prescindere dal fatto che se qualcosa del vecchio o dell’altro è ancora valido è sempre possibile conservarlo) dimostri una logica concorrenziale ormai totalmente introiettata e perfettamente allineata con quello che oggi chiamiamo un po’ sinteticamente ‘capitalismo’. Attenzione però, rifiuto gli intenti ma non proprio i risultati, che molto spesso non sono neanche coerenti con gli intenti. Penso sia più l’atteggiamento che mi infastidisce, non il significato o la forma dell’oggetto o dell’opera in genere.
Io non so bene da dove provengano le idee o le immagini che attraversano la mia mente. Percepisco sicuramente la mia esistenza come una contingenza in quanto non ho deciso di nascere e in generale sono molto scettico riguardo all’esistenza di un vero e proprio libero arbitrio. Sono in balia degli eventi, degli altri e della Storia. So che questa affermazione può sembrare contraddittoria, ma non mi addentrerei oltre nella discussione, sospendo il giudizio a riguardo e mi accontento serenamente dell’illusione di essere libero. Dipingo situazioni, cose o visioni (sempre comunque abbastanza plausibili) che mi capitano per effetto del mio inesauribile stato di distrazione e di ozio. Non so se conosco bene i soggetti che dipingo, non ne sarei così tanto certo. Cioè: sono convinto che si tratti sicuramente di fenomeni fisici e non posso che assistere ad essi contemplandone le sensazioni, riproducendone gli effetti e reinventandone la forma e le superfici nel modo più comprensibile per me e per gli altri. L’apparente naturalismo ‘raddrizzato’ per così dire, e quel tocco di atmosfera silenziosamente metafisica che cerco di restituire nella pittura sono le conseguenze metaforiche del mio modo di pensare e di agire. Una certa geometria e un certa restituzione prospettica che a volte sfocia in assonometria mi aiuta ad alludere in qualche modo alla struttura ideale che noi percepiamo negli oggetti, quel qualcosa di difficilmente afferrabile, di confuso, che sono le invarianti percettive. Il mio approccio è sempre e comunque scettico e sospettoso verso le cose: da ciò deriva proprio la scorrettezza matematica e ottica delle mie rappresentazioni. La mia prospettiva e le mie assonometrie, come la restituzione ottica dei soggetti sono sempre sbagliate. Le prospettive sono intuitive e solo apparentemente corrette. Il naturalismo e il realismo superficiale degli effetti restituiti sugli oggetti contraddice sempre alcuni aspetti del dato reale.
L’unica cosa che posso dimostrare è proprio la mia scorrettezza. –
Percepisco in queste parole, immaginando i tuoi dipinti, un afflato estetico trasversale, capace di unire diverse istanze eterogenee nell’universalità della visione: per quanto “scorretta”, essa trova nel suo essere forma percepibile un’originalità di cui altri medium non dispongono. C’è molta cultura antica in questo: Plotino (riferendosi alle immagini dei primi secoli d. C.) parlava di immagini “trasparenti”, capaci di farci percepire ogni possibile condizione del soggetto raffigurato, in virtù del loro non essere imitazione dello stesso, ma riferimento a-prospettico e a-naturalistico, che consentono l’espasione del nous proprio in quella “struttura ideale” contenuta nella realtà alla quale anche tu fai riferimento; anche la filosofia romana, pur parentesi di quella greca, contiene concetti interessanti, come l’idea di otium, ovvero la contemplazione riflessiva, attività in cui i patrizi si dedicavano nelle ville fuori città, e strettamente legata alle capacità concezionali del cosidetto artifex, colui che, tramite il potere unificatorio della percezione mentale, era in grado di produrre immagini capaci di restituire almeno un’impressione delle idee platoniche, i logoi; questi concetti tipici della cultura detta occidentale, si ritrovano in realtà, formulati diversamemente, anche in oriente. Vengono inoltre ripresi in epoca modernissima, pensiamo alla Recherche di Proust o alla pittura di Giorgio Morandi, capace di schiudere le coltri dell’infinito con delle semplici bottiglie impolverate… Il sensibile, nelle mani dell’artista, per quanto contingente, può diventare un vettore che conduce verso altri lidi, inarrivabili alla comprensione possibile con le sole parole. Ti senti parte di questi processi?
– Direi di sì. Sicuramente la mia massima aspirazione sarebbe proprio quella di avvicinarsi a quell’aspetto dell’estetica di Plotino a cui fai riferimento. Non ho ancora capito con un sufficiente grado di certezza se la pittura può assolvere a questo compito: “far percepire ogni possibile condizione dell’oggetto” nel senso di trovare quel giusto mezzo che salvi le apparenze e che allo stesso tempo possa alludere a un ‘oltre’ puramente mentale, non spaziale e non temporale per così dire. Di solito questo giusto mezzo sta proprio nel rappresentare quella vaga allusione e sintetica tensione tra l’accidentale e il sostanziale. Quindi dipingere l’accidente ‘al punto giusto’, senza sforare nel mero naturalismo ottico che distruggerebbe l’oggetto, dissolvendolo in un caos privo di limiti categorici, facendolo risultare indistinguibile e totalmente fuso nel disordine orgiastico, contraddicendo la sua stessa definizione di oggetto in quanto ente dotato di una qualche permanenza e definito linguisticamente al fine di distinguerlo da ciò che lo circonda. D’altro canto però anche tendendo troppo dalla parte opposta, quella cioè della pura idealità, dell’astrazione estremizzata o anche della semplice stilizzazione simbolica, si correrebbe il rischio di rendere irriconoscibili, indefinibili e incomunicabili tutte quelle caratteristiche peculiari dell’oggetto funzionali ad un coinvolgimento emotivo e mnemonico, sia mio che dell’eventuale fruitore. Potremmo dire che il mio tentativo è quello di mantenermi entro i limiti di un certo ‘buon senso’ della rappresentazione, dove ciò che resta del naturalismo imitativo non è altro che un mezzo finalizzato ad una maggiore comprensibilità, e che permette a me e all’osservatore di oltrepassare l’immagine che da figurativa diventa figurale.
Potrebbe sembrare paradossale ma in questo mio proposito è di fondamentale importanza l’utilizzo della macchina fotografica. La chiamo ‘macchina fotografica’ e non ‘fotografia’, proprio per distinguere la prima dalla seconda in quanto strumento ottico e non linguaggio artistico in un senso più ampio. La fotografia come linguaggio mi è sempre interessata relativamente poco, pur riconoscendone le oggettive qualità documentarie o estetiche. Lo strumento ottico in quanto tale invece mi ha sempre svelato le sue potenzialità sia dal punto di vista espressivo e cognitivo sia dal punto di vista meramente tecnico di risoluzione dei problemi. Lo sguardo indiretto nei confronti di cose e persone che si definisce nel riflesso speculare e nella proiezione ottica all’interno di una piccola camera oscura possiede un senso ricco di riferimenti mitici se non addirittura mitologici. All’origine, seppur mitica, della pittura infatti non ci sarebbe altro che una ‘rappresentazione della rappresentazione’, un ricalco vero e proprio dei contorni dell’ombra di un profilo proiettato su una parete. Trovo sia curioso il fatto che una delle tecnologie emblematiche della modernità industriale, come è certamente la macchina fotografica, possa avere in sé stessa un senso così primitivo nel momento in cui si utilizza lo strumento con una certa consapevolezza storica e mitica, riscoprendone i princìpi e le caratteristiche più semplici. La macchina fotografica, o potremmo dire la luce riflessa e proiettata dalla lente, non fa altro che produrre un vero e proprio calco bidimensionale della realtà fenomenica circoscritto dai limiti rigorosi dell’inquadratura. Questo è l’approccio mentale che intercorre tra me e questo strumento: utilizzo il calco e i limiti che lo appiattiscono per documentare nel momento giusto la situazione e le forme da ridefinire con la pittura. Proprio in quel momento visualizzo perfettamente l’idea dell’oggetto nella sua chiarezza e intelligibilità: il calco visivo di cui mi servo non è altro che una cristallizzazione anche se ancora imperfetta della struttura e degli accidenti del soggetto. Da ciò deriva un’altra caratteristica del mio operare: la necessità della visione indiretta della realtà. Per il mio lavoro è necessario spezzare la reciprocità del vedere e dell’essere visto, sia che si tratti di persone sia si tratti di cose e oggetti. Lo strumento fotografico mi permette di non correre dietro alla natura e alla sua continua e inafferrabile mutevolezza, permettendomi di mantenere uno sguardo distaccato e non troppo coinvolto nel flusso fenomenico. In un centesimo di secondo posso cogliere tutti gli elementi che mi servono per ridefinire pittoricamente l’idea senza la presenza persistente dell’oggetto da dipingere, e soprattutto mi consente di dipingere cose diverse sempre nello stesso luogo di lavoro, cioè il mio studio. Potremmo dire, utilizzando le parole di Calvino, che la realtà nuda e cruda è troppo “opaca” per essere rappresentata coerentemente. Il mondo è la Medusa che ci pietrifica, che ci paralizza con la sua inafferrabilità: per essere sconfitta o controllata necessita di una visione indiretta, deve essere riflessa come nello scudo di Perseo. –
E’ curioso perché la macchina fotografica, quando iniziò ad esser popolare tra i pittori (già Courbet ne faceva uso, ai tempi a Parigi si vendevano fotografie con pose predefinite di modelli specificatamente per l’uso pittorico) contribuì proprio a quel deragliamento del “buon senso” entro cui tu, invece, desideri mantenerti. L’arte impressionista, pur di fare ciò che la fotografia non poteva, inizia letteralmente a sfaldare il significante: quello che è successo dopo è storia; tu associ la macchina fotografica ad una mitologia, il suo avvento ha stabilito uno spartiacque nel modo di concepire le immagini, riportando il linguaggio visivo ad un suo grado 0 che, soprattutto in pittura, si è dovuto riformulare in base alle nuove possibilità tecniche. Però la tua visione è in questo caso molto ‘illuminista’: tratti il fenomeno come qualcosa che devi in qualche modo imbrigliare e ne dai per scontata l’ineffabilità, se tentato di carpire coi soli mezzi della nostra visione autonoma.
Nonostante io nutra delle perplessità riguardo le conseguenze dell’uso della macchina fotografica, sono altrettando dubbioso nei confronti del purismo più manicheo che ne cancellerebbe l’uso. Sembra che tu sia arrivato ad una giusta dose di compromesso. Ti ritrovi in una posizione idealmente ‘di sintesi’ rispetto i percorsi della storia dell’arte recente? L’utilizzo di una visibilità apparentemente ottica, la quale maschera però degli errori prospettici voluti, delle assonometrie, ti riconduce ad una sorta di primitivismo adimensionale, come dicevo prima: hai intuito i limiti del fotorealismo e sei intervenuto conferendogli quell’artificio umano, l’errore e la sintesi. Le tue opere appaiono per questo motivo anche inquietanti: mostrano chiaramente l’impossibilità di carpire quel qualcosa che trama oltre l’apparenza. Talvolta sfoci addirittura nel simbolismo schietto, mi viene da pensare al recente Kosmos (ritratto di Oxana), oppure a Rosetta in giardino. In queste cose mantieni integra una certa italiana trasversalità, appunto sintetica, che in pittura fu detenuta, ad esempio, dai fratelli De Chirico. Tu stesso hai già usato il termine ‘metafisico’ per descrivere il risultato della tua pratica, ma vedremo mai uno Sciortino del tutto oltre la realtà?
In verità non concepisco l’avvento della macchina fotografica come un vero e proprio “spartiacque”, perché non riesco a leggere e interpretare la Storia (soprattutto quella della tecnologia) secondo questa logica. Riconosco però che per alcuni artisti della metà dell’ottocento in effetti lo è stato, nel bene e nel male: basti pensare alle paranoie dei pittori accademici francesi o ad alcuni puristi italiani; o come la fotografia è stata accolta da alcuni macchiaioli. Credo che il concetto stesso di “spartiacque” faccia parte di un modo di concepire la storia dei fatti umani che risulta essere sicuramente molto utile ma allo stesso tempo semplificatorio e appunto ottocentesco, direi anche progressistico, forse addirittura intriso di un residuo psicologico di derivazione Cristiano-Giudaica inevitabilmente introiettato da tutti noi occidentali.
– In realtà la Storia, anche se concepita qui e ora, dovrebbe anche essere letta nella sua lentissima evoluzione priva di tappe troppo nette (e la reazione entusiasta o paranoica degli artisti ottocenteschi è proprio la dimostrazione di una certa idea ancora superstiziosa dell’evoluzione delle cose umane), mettendo più in discussione il fatto che il tempo storico non è necessariamente un lungo segmento con un inizio ed una fine a sua volta diviso in tanti piccoli segmenti che definiscono gli spartiacque (concezione occidentale religiosa appunto, forse anche marxista, anche se Marx forse avrebbe usato una semiretta segmentata al contrario, con il punto iniziale posto alla fine, negando così l’inizio ma definendo nettamente la fine), ma può essere visto come un insieme di infinite rette parallele, prive quindi di un inizio e una fine, di una creazione e di una fine di tutto, e i cui fatti linguisticamente determinati e opportunamente collocati proseguono contemporaneamente, convivono, a volte rallentano o si fermano per poi ripartire e trasformarsi in qualcos’altro per l’eternità. Da questo mio modo di negare una certa filosofia della Storia deriva appunto il senso mitologico e atemporale che caratterizza tutti i fatti storici e le ‘invenzioni’ (anche questo, termine molto ristretto, limitante e contraddittorio). La macchina fotografica infatti, se si smette per un attimo di identificarla con il brevetto del 1839 e la si vede come l’ennesima innovazione tecnica applicata ad una tecnologia relativamente rudimentale e antichissima, può assumere questo senso di cui parlo. Nell’ottocento viene fissata chimicamente l’immagine su una lastra, e questo fatto viene comprensibilmente interpretato in modo forse un po’ affrettato come un modo di realizzare un’immagine naturalistica in maniera automatica (infatti oggi, ormai totalmente immersi in un tecnocosmo di applicazioni di fotografia digitale e di intelligenza artificiale, diremmo, forse un po’ sorridendo, che era ‘semiautomatica’ perché sappiamo quanto fosse necessario l’intervento umano per lo scatto, per l’inquadratura, la composizione, il bilanciamento della luce eccetera… Senza pensare alla mirabile complessità della costruzione dello strumento fotografico e delle intuizioni e soluzioni tecniche dei fotografi). La proiezione fotografica per mezzo di lenti o specchi a quanto pare ha delle origini molto antiche , anche se per quanto ne sappiamo la sua applicazione pittorica risale a qualche secolo fa: basti pensare alle differenze ottiche palesi nella risoluzione pittorica tra artisti quattrocenteschi italiani e fiamminghi, per non parlare anche del semplice fatto che è molto improbabile che nell’arco di meno di un secolo, la pittura con tendenze naturalistiche illusionistiche si sia sviluppata dal nulla e senza l’ausilio di strumenti ottici o, per chi non li usasse, senza esserne influenzato quantomeno negli effetti. Alla fine potremmo dire che la prospettiva italiana non è altro che una sorta di risoluzione di problemi ottici in mancanza di strumenti ottici, strumenti che invece a quanto pare possedevano i fiamminghi i quali almeno agli inizi del quattrocento, data la rudimentalità delle lenti e la scarsa risoluzione ai bordi dell’immagine proiettata, trovarono una sorta di strano compromesso tra ottica e prospettiva intuitiva (ricordiamo che nelle Fiandre già da molto prima dell’invenzione del telescopio seicentesco si lavorava all’affinamento delle lenti che poi, gradualmente e non all’improvviso, portarono all’applicazione telescopica).
Da questa premessa necessaria a chiarire la mia posizione in effetti potrei dire di aver trovato una sintesi rispetto alla pittura recente e non solo. Credo sia proprio in questa negazione dello spartiacque storico di cui parli che consiste il buon senso a cui aspiro: capisco i motivi che hanno spinto vari artisti dalla metà dell’ottocento fino al novecento inoltrato a sperimentare soluzioni pittoriche che superassero il naturalismo fotografico, negandolo del tutto o assecondandolo a volte troppo meccanicamente, anche se non ne condivido del tutto le premesse. Come giustamente dici tu tra questi due secoli molti artisti hanno riportato il linguaggio visivo al suo grado 0 anche come conseguenza della fotografia, e potremmo dire anche a causa di una certa perversione irrazionale di innovazione del linguaggio a tutti i costi (quasi tutti gli artisti d’avanguardia pensavano un po’ ingenuamente che bisognava fare con la pittura solo ciò che la fotografia non poteva fare, non pensando al fatto che l’immagine del quadro potenzialmente ‘fotografico’ ha infinite possibilità di differire dalla fotografia di riferimento e che l’immagine in sé, nella pittura, non è l’unica cosa che conta). Le possibilità tecniche della pittura esplorate dalle avanguardie ormai includono anche la fotografia come linguaggio e la macchina fotografica come strumento di rilevazione e documentazione. Il fatto è che molte tendenze della rappresentazione classico-naturalistica si erano semplicemente indebolite e scaricate, sia a causa della presenza della fotografia, del cinema e del linguaggio pubblicitario, sia soprattutto per motivi ideologici, cedendo troppo spesso il passo ad un’eccessiva arbitrarietà che non teneva conto dell’importanza del potere e delle potenzialità delle forme oggettive. Fare ‘il classico’, o quanto meno provarci, e soprattutto identificare quello buono, è sempre più difficile dell’avanguardia perché è necessario mantenersi entro certi limiti all’interno dei quali l’arbitrio non sovrasta tutto il resto. Ma per fare ciò credo si debba mettere un po’ da parte il proprio individualismo egoriferito, e sappiamo bene che da duecento o trecento anni a questa parte questa cosa non è stata possibile. Credo di essere arrivato ad una giusta dose di compromesso semplicemente perché utilizzo lo strumento fotografico senza rinunciare troppo ai miei stereotipi formali, alle mie distorsioni cognitive e tutto ciò che ne consegue, che si tratti di errori o caratteristiche positive del segno. Questo compromesso riguarda anche la mia consapevolezza dell’impossibilità di imbrigliare il fenomeno con la macchina fotografica: non posso congelare realmente nulla, semplicemente ho bisogno di un documento visivo trasportabile, fonte di dati formali, che mi consenta di ridefinire e reinventare comodamente nel mio studio il soggetto da dipingere. Il buon senso di cui parlo riguarda anche il dato comunicativo: siamo tutti inevitabilmente influenzati dal realismo degli effetti e dalla resa fotografica, abbiamo introiettato quasi totalmente un’idea fotografica di alcuni aspetti di ciò che ci circonda. Quindi non faccio altro che tentare di parlare entro i limiti della lingua che la maggior parte delle persone conoscono. L’eventuale realismo delle mie immagini non è il fine, è solo un mezzo funzionale alla comprensione.
Detto questo non so se vedremo uno Sciortino del tutto oltre la realtà, perché ancora non so bene cosa significhi la parola ‘realtà’ e quali limiti concettuali possa avere. I miei ultimi dipinti ai quali ti riferisci dimostrano questa attenzione momentanea verso questo tema e delle sue potenziali implicazioni nella costruzione dell’immagine: un’oscillazione tra il reale e l’impossibile che si concretizza in qualcosa di plausibile, anche se a dire il vero in questa ricerca non ci sono troppe differenze con i lavori passati. E mi riferisco soprattutto a Rosetta in giardino, nel quale presumibilmente, chi legge il titolo e guarda l’immagine pensa che Rosetta sia la ragazza che prende il sole in giardino, quando in realtà Rosetta è la sonda che nel 2014 raggiunse e fotografò la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, quest’ultima rappresentata come un plausibile masso grigio proprio davanti il muretto di cemento grezzo dipinto quasi come se fosse l’universo stellato in cui la cometa è immersa. Negli ultimi dipinti più criptici che ho realizzato infatti la narrazione è incentrata sul rapporto di continuità e allo stesso tempo di differenza tra ciò che accade sulla terra e ciò che accade nello spazio cosmico. Tutto ciò che sembra andare oltre la realtà si riduce ad un fatto linguistico, di definizione concettuale: il metafisico è ciò che non può essere detto a parole, ciò che sta oltre i fenomeni e di cui abbiamo solo una vaghissima idea molto imprecisa e intrisa di mistero. Io per adesso con la pittura non credo di poter andare troppo oltre la metafisica delle apparenze.
Con queste ultime opere stai quindi facendo del metalinguaggio, quasi a voler includere certi giochi dell’arte concettuale (molto basata sull’allusività delle figure retoriche e sulla conseguente riflessione ontologica sul soggetto/significante) nel medium della pittura. “Tutto ciò che sembra andare oltre la realtà si riduce a un fatto linguistico” mi sembra poi una frase molto wittengsteiniana: le tue immagini mostrano il visibile, ma possono riferirsi anche all’invisibile sul quale, però, di fatto ‘tacciono’, continuando a sembrare altro da ciò che alludono, come nel caso di Rosetta. Puoi fare altri esempi di tue opere nelle quali intavoli simili processi di autoriflessione linguistica?
– Nella mia produzione complessiva ci sono pochi esempi simili agli ultimi dipinti che ho realizzato. L’elemento di riflessione comune a tutto il mio lavoro comunque, come dici giustamente tu, è proprio il fatto di mostrare il visibile riferendosi all’invisibile. Ad esempio nel dipinto Pavimento dello studio di Primo Conti ho indirizzato l’attenzione di chi guarda sull’unico elemento formale che allude alla presenza/assenza del pittore nel suo studio: la macchia nera sul pavimento infatti non è altro che l’alone di colore accumulato formatosi in 40 anni di lavoro nel punto esatto in cui Conti posizionava il cavalletto per dipingere. Di fatto è una sorta di ombra permanente o una sindone, non tanto della forma del corpo del pittore ma del suo lavoro e della sua attività, che ha lasciato un’impronta specifica che allude direttamente alla Pittura. Alla fine si potrebbe dire che si tratta di uno strano caso di meta-pittura. Oppure l’ultimo paesaggio che ho realizzato dal titolo Paesaggio toscano senza cipresso è un caso in cui ho giocato con l’aspettativa che potrebbe scaturire prima dall’immagine e in seguito dal titolo. Il paesaggio toscano che comunemente ci immaginiamo raramente è privo del classico cipresso e in questo caso, grazie alla definizione data dal titolo, creo nel fruitore una doppia immagine differente: il dipinto visibile che è la prima cosa che si vede, e il titolo che pur non negando l’immagine ne crea un’altra diversa nella mente di chi guarda. L’immagine mentale di ciò che non c’è ma che dovrebbe esserci si sovrappone inevitabilmente all’immagine che si osserva. Chi guarda il quadro e legge il titolo non può fare altro che constatare che manca qualcosa di ‘essenziale’ all’immagine riferita specificatamente al paesaggio toscano (infatti non avrebbe avuto lo stesso significato contraddittorio se si fosse trattato di un paesaggio siciliano senza cipresso). A proposito di paesaggi siciliani, nei miei lavori sulle rovine di Selinunte, anche se non ho giocato esplicitamente con il rapporto tra il titolo e l’immagine, ho tentato di concentrare l’attenzione sull’aspetto più contradditorio di quei luoghi che fanno parte ormai della mia memoria e dell’idea che si ha in genere della Sicilia e della Magna Grecia: la percezione di elementi architettonici come effettivi elementi naturali. Di fatto noi vediamo delle architetture crollate i cui singoli elementi sono ormai tornati a mimetizzarsi nella natura del luogo, come se la natura stesse palesemente facendo tornare indietro nel tempo geologico i massi scolpiti dai greci per la costruzione dei templi. Selinunte la si può vedere in un’ottica ambigua, che può contraddire il fine a cui è destinata l’area archeologica che ne contiene i resti: dalla natura all’architettura per poi tornare inevitabilmente alla natura, nonostante i confini imposti dalla riserva archeologica che musealizza un’intera area paesaggistica la cui spontanea e naturale esclusività, per le persone che vivono quei luoghi da sempre, viene negata per la smania di conservazione tipica del mondo occidentale moderno. Nella percezione che ho di quei luoghi e nella restituzione che ne do nella pittura c’è evidentemente anche della romantica nostalgia e un atteggiamento malinconico rispetto a ciò che Selinunte in realtà non è e non potrà mai essere: semplicemente paesaggio. La pittura mi consente di donare l’esclusività di quei luoghi a chi fruisce dell’immagine, negandone l’eccessiva idealizzazione pittoresca, nella speranza che queste immagini possano influire sulla percezione di chi guarda arricchendone le possibilità interpretative. Come vedi ciò che costituisce l’elemento ‘invisibile’ nei miei lavori non si manifesta sempre allo stesso modo, per allusioni, riferimenti o concettualismi, proprio perché non ho una linea di ricerca ben precisa: trovo semplicemente modi diversi tra loro di dare senso alle immagini. Infatti, ad esempio, nei miei piccoli dipinti di interni o di oggetti, spesso mi concentro su dettagli tagliati proprio per far deragliare l’attenzione dal soggetto (a volte si tratta di un semplice angolo o frammento) verso l’esterno dell’immagine, lasciando immaginare il resto del soggetto non visibile. I miei frammenti di oggetti sono frutto della mia stessa distrazione, e a loro volta inducono il fruitore a distrarsi ulteriormente dal centro dell’immagine per andare oltre i limiti imposti dal taglio dell’inquadratura. Il soggetto dell’immagine diventa così paradossalmente oggetto di attenzione e distrazione allo stesso tempo: l’osservazione diventa contemplazione della propria distrazione. Nonostante tutte queste possibili interpretazioni e tutti questi miei intenti semantici più o meno riusciti, ciò che conta è un giusto equilibrio tra le concezioni della Pittura come fine e della Pittura come mezzo, entrambe sicuramente intrise di potenziali significati intrinseci in grado di ampliare il nostro modo di vedere le immagini, osservare il mondo e pensare i concetti.
Contemplare la propria distrazione è un’idea interessante: oggi viviamo in un mondo in cui siamo sempre ‘distratti’ in senso lato, non solo dalla quantità di stimoli audiovisivi cui siamo sottoposti, ma anche dalle normali attività di quotidiana routine apparentemente normali, come lavorare: è difficile, da coscienti di certi scenari raccapriccianti, non sottoscrivere anche solo parzialmente a certe pessimistiche visioni marxiane e neotali. Molta gente vive alienata, e anche molta gente intelligente e colta è in realtà già spacciata in questo senso. E stiamo parlando di persone relativamente agiate, le quali non hanno però i mezzi per liberarsi della schiavitù mentale cui siamo indotti: come si diceva prima, la pittura sa essere un espediente per godere dell’otium, la condizione di contemplazione riflessiva senza magari nemmeno un fine esatto, il vagheggiare della mente sino a farla entrare in uno stato meditativo. Questa tua frase mi ha riportato a quel concetto (anche perché traduce efficacemente in termini scherzosi l’idea plotiniana): credo che il controsenso di soffermarsi a guardare ‘la distrazione’, pur nell’osservazione del soggetto da cui ‘ci si distrae’, sia un modo per dimostrare la polisemia di cui il linguaggio pittorico è capace quando bene ammaestrato. L’immagine pittorica comunica sempre anche altro da ciò che effettivamente essa è o rappresenta: la si guarda, ma la mente raggiunge altri lidi, pur continuando a percepire il significante dell’immagine e il soggetto della medesima. Il distrarsi è oggi invece un’attività compulsiva: ci si distrae per non vedere, mentre la pittura distrae per far vedere meglio, evidenzia i meccanismi stessi del pensiero per immagini.
Esso corre nelle lussuriose pieghe della materia del dipinto.
Vorrei passare da questi argomenti a fatti squisitamente più pratici. In questa sfilza di dualismi e contraddizioni che stiamo elencando, c’è ovviamente quella che lega il concetto astratto alla materia fisica: l’opera d’arte è materia grezza plasmata. L’inerenza del concetto trasformativo è alla base del fascino delle immagini dipinte: guardando un quadro, il cervello percepisce anche le informazioni legate alla sua matericità, cioè pennellate, granulosità e spessori plastici. Seguendone il moto di queste tracce, riusciamo a immaginare implicitamente i movimenti del pittore che realizza il dipinto. Tu hai uno stile pittorico meticoloso, come ti rapporti con la materia pittorica? Che tecniche usi per realizzare le tue opere, supporti…?
Le tecniche che utilizzo e le modalità processuali che adotto sono estremamente semplici: dipingo principalmente ad olio su supporti di cartone, cartonlegno o tavola. Raramente utilizzo tele montate su telai perché le mie esigenze tecnico-espressive esigono che le dimensioni del dipinto siano relativamente piccole e le superfici sufficientemente levigate. Utilizzo pochi mezzi, di solito una matita per definire i contorni del disegno, 2 o 3 pennelli di martora molto piccoli e non più di 8 o 9 colori in tubetto. I cartoni li preparo con del gesso acrilico leggermente allungato, mentre le tavole con colla di coniglio e gesso. Utilizzo dei medium per dipingere altrettanto semplici perché per adesso non mi interessano molto le sperimentazioni alchemiche nella pittura: di solito uso un medium composto di trementina, olio di lino o di noci e Liquin per accelerare un po’ l’essicazione e avere una superficie più uniforme. Il procedimento pittorico a cui sono abituato richiede almeno tre strati di pittura, il primo dei quali diluito con trementina per ottenere un effetto quasi acquerellato, per procedere in seguito negli strati successivi con una materia pittorica più spessa e pastosa nelle zone più in rilievo e più trasparente e sottile nelle zone d’ombra, anche se non proprio in tutti i casi. Negli ultimi strati di pittura sovrappongo delle velature di colore molto sottili che a volte sono previste e chiaramente immaginate dall’inizio del dipinto, ma in molti casi non lo sono e sono frutto di una certa improvvisazione: infatti buona parte delle velature finali mi servono per creare una trama vibrante sulle superfici, per correggere la luminosità o modificare alcuni colori smorzando l’eccessiva saturazione o al contrario ravvivando le tinte. L’insicurezza dei mezzi, in conseguenza del fatto di non essere mai stato particolarmente dotato di un qualche talento, e il mio stentato controllo su di essi, in buona parte dei casi, mi portano ad essere molto incerto nell’esecuzione: sotto gli strati superficiali della maggior parte dei miei dipinti ci sono infatti innumerevoli correzioni di errori, quest’ultimi a volte anche madornali. Questo fatto credo sia dovuto alla mia difficoltà nell’immaginare immediatamente e in maniera lucida l’immagine che andrò a realizzare nel suo insieme, costringendomi a fare diversi tentativi prima di ottenere un risultato soddisfacente. Quando immagino un dipinto, molto spesso cado facilmente nel tranello della sensazione e ciò mi porta a illudermi di essere interessato a dipingere tutta la situazione nel suo insieme. Mi immagino ‘già dipinte’ molte cose che vedo, mentre molte altre no. Queste ultime sono quasi come se non le vedessi, come se le concepissi con altri mezzi diversi dalla pittura, o semplicemente come se le vedessi per quello che sono, senza andare troppo oltre le possibilità potenziali delle forme da plasmare. Infatti le parti meno riuscite dei miei quadri sono quelle tecnicamente immaginate peggio, quelle che fanno inevitabilmente parte del contesto dell’immagine e che vanno rappresentate necessariamente ma che non sono riuscito a risolvere all’inizio del concepimento o per le quali non ho trovato delle opportune soluzioni pittoriche durante il processo di realizzazione. I formati ridotti dei miei dipinti, soprattutto nel caso delle miniature, mi hanno svelato pian piano la possibilità di gestire l’immagine pittorica e la varietà della materia che la compone con un maggiore senso della sintesi: il formato ridotto mi costringe ad utilizzare pochi mezzi (a volte anche un solo pennello) per costruire l’immagine entro i limiti imposti dal mezzo stesso. Se dovessi dipingere le mie immagini in un formato più grande probabilmente mi addentrerei troppo nel dettaglio minuzioso oppure, costringendomi ad essere più sintetico e realizzando il dipinto dalla giusta distanza di osservazione, sacrificherei la visione ravvicinata. La scelta del piccolo formato è funzionale proprio a questi due fatti: per autolimitarmi tecnicamente al fine di ottenere la giusta risoluzione dell’immagine; e per dare la possibilità a chi guarda il quadro di apprezzarlo ed esplorarlo dalla giusta distanza, ovvero quella dalla quale io dipingo e vedo chiaramente gli spessori della materia o la direzione delle pennellate, e che nel caso delle miniature corrisponde alla visione simultanea dell’immagine da lontano e da vicino. Credo infatti sia estremamente importante vedere i quadri da vicino, proprio per poter apprezzare al meglio la matericità e tutto ciò che di controllato o casuale possa esserci nella stesura della pittura: il racconto dell’immagine passa anche dalla costruzione più o meno meditata per mezzo della consequenzialità dei segni grafico-pittorici che, come tracce, definiscono i limiti del corpo (e quindi dalla mente) del pittore e in quanto simboli alludono alla straordinaria ed esclusiva capacità ancestrale di cui gli esseri umani di qualsiasi tempo e luogo sono stati dotati: produrre segni carichi di significato. –
Federico Zeri diceva che nella pittura europea prevalgono due correnti: quella nostrana, ove l’immagine è concepita come un insieme di elementi funzionali all’univocità della visione d’insieme, e che solo successivamente permette la discesa entro i dettagli; in contrapposizione alla concezione fiamminga, la quale invece esige dall’osservazione la lettura dell’opera a partire dai dettagli, singoli segni isolati il cui diversificato insieme restituisce una totalità solo gradualmente svelata. Guardare un quadro di Bosch da lontano significa quasi non vederlo, mentre vale il contrario per una pala d’altare della Roma controriformata, ad esempio. Tu mi pare appartenga alla categoria fiamminga, nonostante la tua nazionalità: ma d’altronde la pittura è linguaggio storicamente cosmopolita, pur mantenendo l’apparenza di precise genealogie formali, travalicava i confini nel suo mutare organicamente di territorio in territorio (pensiamo ad Antonello da Messina e Durer, artisti ibridi tra l’Italia meridionale e il nord Europa).
Se tu contempli il limite delle dimensioni dei tuoi supporti come un modo di incanalare un tuo difetto per renderlo pregio, oggi la pittura odierna è abbastanza stantia, forse proprio perché non contempla l’idea di un limite, nemmeno quello del confine interregionale ‘da varcare’. Non esistono più, in genere, delle vere diversificazioni stilistiche tra artisti provenienti dall’area liberal capitalista del mondo: se pensiamo che dalla Cina moltissimi artisti vengono in Europa ad assimilare l’arte occidentale, è chiaro che non possiamo più affidarci completamente all’antica (benché ancora necessaria) idea di ‘nazione’ per definire il carattere di un artista. Non sempre, almeno.
Volevo chiederti, oltre a cosa ne pensassi di questa omologazione globale, tendenzialmente assestatasi su un fare astraente o un concettualismo politicheggiante, se esistono artisti viventi che stimi particolarmente, siano essi inseriti in queste logiche che totalmente estranei.
– La risposta a questa domanda per me molto difficile, potrebbe essere viziata da un pregiudizio generico dettato dalla mia stessa ignoranza nei confronti dell’arte contemporanea che viene prodotta nel mondo. Fondamentalmente non mi piace quasi nulla di ciò che conosco in ambito pittorico e artistico contemporaneo in generale (nella musica e nel cinema non provo però la stessa indifferenza). Stimo molto i miei amici artisti, qui in Toscana, perché sono quelli che conosco meglio e più profondamente, e alle cui opere ho accesso diretto, in particolare uno dei miei più cari amici e uno dei più bravi pittori che conosco, Jacopo Ginanneschi. A parte il caso di Hockney, sui social network seguo molti pittori inglesi contemporanei che, anche se non mi entusiasmano particolarmente e sono abbastanza lontani da quello che faccio, riesco ad apprezzare per le competenze, il controllo tecnico e un certo gusto nella rappresentazione e nella costruzione del quadro. Ad esempio qualche ritratto di Benjamin Sullivan o i disegni di Lewis Chamberlain; oppure alcune opere di Simon Quadrat e le tempere all’uovo di Anthony Williams. Chiaramente si tratta di artisti che non entreranno mai nel flusso del circuito ufficiale dell’arte contemporanea, e che fanno parte di piccoli sistemi paralleli più localizzati. Diciamo che, come accade spesso quando ci si imbatte nell’arte del nostro tempo, la mia reazione di fronte alle opere della stragrande maggioranza degli artisti visivi risulta essere quasi sempre priva di autentico coinvolgimento, come se tutto ciò che viene prodotto fosse fatto all’insegna del semplicemente ‘interessante’. E questo accade forse per l’eccessivo concettualismo o al contrario per la tendenza quasi decorativa e formale di cui sono intrise le opere pittoriche. Ad esempio Richter, o in Italia Samorì, sono pittori sicuramente apprezzabili e, nonostante il fatto che siano molto diversi tra loro, negli intenti e nei risultati, sembra quasi che siano più artisti concettuali che usano la pittura che non pittori nel vero senso della parola, come poteva essere un De Chirico, un Morandi o un Balthus. Attualmente ho le idee un po’ confuse a riguardo, anche perché non essendo un artista-ricercatore e un cultore d’arte, non ho il tempo da dedicare alla ricerca e alla fruizione di ciò che altri artisti viventi fanno, perché sarebbe necessario anche viaggiare molto, visitare molte mostre, fiere e leggere molte riviste per essere costantemente aggiornato su ciò che accade. Poi in generale, dato il mio scetticismo e la mia diffidenza verso le immagini e verso gli artisti in genere, non riesco quasi mai a coinvolgermi emotivamente o intellettualmente, cosa questa che invece mi riesce naturale nel momento in cui produco il mio lavoro.
Per il resto non mi piace pensare che ci sia un’effettiva omologazione nella produzione dell’arte al giorno d’oggi anche se in molti casi è sicuramente vero e del tutto normale, come è sempre stato in età moderna. Il fatto più impressionante più che altro è la velocità di diffusione e condivisione delle esperienze e delle informazioni che, da una parte, complica l’identificazione e la definizione di determinate produzioni all’interno di limiti ermeneutici generalmente a noi più noti, dall’altra rende inafferrabile qualsiasi tendenza unitaria e circoscritta. Oggi mi sembra che un artista possa attingere liberamente, arbitrariamente o casualmente da una quantità di situazioni e immagini sterminata, e non trovo che sia necessariamente un male. Cerco di avere sempre e comunque molto rispetto del lavoro altrui perché credo che nella maggioranza dei casi in cui si fa arte a livelli medio-alti, ed è riconoscibile in qualche modo una certa qualità e una certa direzione ideale negli intenti a prescindere dal gusto personale, ci siano sempre delle cause consce e inconsce e tutta una serie di stimoli a cui gli artisti sono inevitabilmente esposti e dei quali non si può avere né il totale controllo né una sufficiente consapevolezza. –
Devo ammettere che la tua neutralità mi disarma un po’, ma è anche bello vedere come sia possibile rimanere imparziali di fronte a sistemi di iniquità critica, laddove si riesce a trovare una propria dimensione espressiva come mi sembra tu abbia fatto. Siccome credo siamo giunti ad un punto oramai quasi morto, avendo sviscerato abbondantemente le tue idee, ti chiedo come ultima domanda se c’è qualcosa che avresti voluto ti chiedessi: fatti una domanda e risponditi.
“Dove ti vedi tra dieci o vent’anni?”
– Domanda sciocca ma necessaria. Data la mia esperienza passata nell’essermi posto più volte la stessa domanda, e non avendo avuto il minimo riscontro nelle mie seppur vaghe previsioni, direi che mi vedo in una situazione abbastanza simile a quella attuale, priva di grandi eventi o cambiamenti personali, sia dal punto di vista carrieristico che più prettamente soggettivo e intimo. Naturalmente non penso la stessa cosa riguardo al mondo che mi circonda e verso il quale la mia comprensione va gradualmente scemando. Ho paura che faremo sempre più fatica a convivere insieme a causa principalmente delle tensioni che si creeranno tra le varie culture, dominanti e non, e a causa del fatto che la vita cui siamo abituati cambierà notevolmente e richiederà uno sforzo psicologico e materiale non indifferente da parte di tutti. Ciò che mi preoccupa, in quanto individuo disadattato, è proprio il rapporto tra lo sforzo di mantenere intatta la continuità della mia vita psichica e i cambiamenti (a volte anche repentini) a cui adeguarsi inevitabilmente. Per il resto mi auguro di poter vivere al meglio con me stesso e con gli altri in questo lasso di tempo che separa la mia esistenza dal nulla, e il mondo in cui vivo dalla sua inevitabile e lenta distruzione.